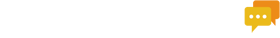di Riccardo Maggioni*
di Riccardo Maggioni*
Nel rispondere ad una domanda rivoltagli il 4 ottobre 2018 all’inaugurazione del Congresso Nazionale Forense di Catania, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha affermato tra l’altro che sulla base dei dati rilevati dal ministero la mediazione obbligatoria costituisce “un passaggio totalmente inutile in alcuni settori”, alludendo evidentemente al fatto che banche e assicurazioni disertano sistematicamente – salvo eccezioni – il primo incontro di mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010.
Così stando le cose, secondo alcuni sarebbe il caso di adeguare le norme a tale situazione rendendo meramente facoltativa la mediazione, nel senso di eliminare per istituti di credito e compagnie assicurative l’obbligo di partecipare al primo incontro valutando in tale sede l’opportunità di proseguire o meno nel procedimento, prosecuzione che già ora – si badi bene – è meramente potestativa per tutte le parti, rimessa cioè alla loro libera volontà.
In buona sostanza, dinanzi a una sorta di “disobbedienza civile” sorprendentemente attuata da soggetti sottoposti a un regime di vigilanza amministrativa per assicurare la scrupolosa osservanza delle norme nei mercati regolamentati in cui operano, la suddetta impostazione si propone di premiare tale condotta ben poco collaborativa (per non dire apertamente ostruzionistica) adeguando ad essa l’ordinamento e rinunciando così tout court agli obiettivi di interesse pubblico che il legislatore si era prefissato di raggiungere attraverso l’istituto della mediazione.
Se peraltro la rinuncia a promuovere la mediazione in settori di rilevanza pubblica quali quello bancario e assicurativo appare mortificante e inaccettabile, d’altro canto nemmeno si può ignorare come sia intuitivo che la materia in sé mal si presta a interventi d’autorità.
E infatti, per non essere “un inutile passaggio” l’istituto della mediazione presuppone la fattiva e convinta collaborazione delle parti, che non può essere imposta con provvedimenti imperativi ma richiede già dal primo incontro la consapevole adesione dei partecipanti, debitamente persuasi circa la reciproca utilità di una negoziazione cooperativa e disposti quindi a prendere seriamente in considerazione tale ipotesi con l’ausilio del mediatore terzo nel suo ruolo di facilitatore.
A mio avviso, una maggiore apertura da parte di banche e assicurazioni rispetto alla mediazione può risultare possibile, ove venga debitamente chiarito che lo strumento non costituisce una mera misura deflattiva del contenzioso giudiziale bensì va inquadrato nel tema della responsabilità sociale d’impresa, riguardando a tutti gli effetti la gestione efficace delle problematiche di impatto sociale ed etico dell’attività aziendale.
Come può essere facilmente verificato, in particolare nei siti web istituzionali del settore bancario e assicurativo, nel mondo imprenditoriale si è venuta formando una sensibilità sempre più acuta rispetto a buone prassi di cui sono sintomatici, ad esempio, i cd. “bilanci sociali” adottati per certificare un alto profilo etico allo scopo di ottenere legittimazione morale per l’impresa che pur perseguendo un – lecito – profitto contribuisce a migliorare la qualità della vita di tutti i consociati con iniziative di impatto sociale positivo.
Non può revocarsi in dubbio che tra tali iniziative va annoverato il fattivo utilizzo della mediazione, che ha una funzione in senso lato pedagogica di cui oggi c’è estremo bisogno, perché promuove la gestione dei conflitti in maniera civile, responsabile e autonoma.
Partecipare invero al primo incontro di mediazione ascoltando il cliente personalmente presente, al di là della sua natura di incombente previsto dalla legge, costituisce condotta conforme alla responsabilità sociale della banca o dell’assicurazione, laddove il rifiuto di presenziare ne è al contrario una plateale negazione, passibile financo di minare la credibilità delle buone intenzioni manifestate in altri contesti.
Per offrire un ulteriore e finale argomento di riflessione, vorrei altresì ricordare come negli ultimi anni gli studi dell’economia comportamentale, nel cui ambito la psicologia cognitiva indaga modalità e procedure utilizzate dagli attori del mercato nelle loro decisioni quotidiane, abbiano messo in luce che tali attori sono dotati di cd. “razionalità limitata”, risultando così ben lontani dal modello del tutto fittizio e irreale di soggetto economico adottato dalla teoria economica classica.
Sul presupposto di tali studi è stata così autorevolmente prospettata un’inedita tecnica legislativa che punta a raggiungere obbiettivi di pubblico interesse attraverso l’utilizzo di incentivi modulati sulla base dei processi cognitivi, piuttosto che mediante comandi imperativi, predisponendo una “architettura delle scelte” idonea a promuovere decisioni congrue e opportune da parte di tutti i soggetti portatori di interesse.
Come molti sapranno, il manifesto di tale approccio alla politica legislativa ed economica è costituito dal libro “Nudge. La spinta gentile” pubblicato in Italia nel 2009 e i cui autori sono Richard H. Thaler, padre dell’economia comportamentale insignito del premio Nobel nel 2017, nonché Cass R. Sunstein, giurista della Harvard Law School già nominato consulente per il settore regolamentare dal presidente Obama.
Di recente, una sintesi efficace e aggiornata delle tesi del nudge e del dibattito che hanno suscitato può poi rinvenirsi nel libro “Oltre il nudge” pubblicato nel corrente anno da Riccardo Viale, professore di economia dell’Università di Milano Bicocca.
Ancorché nudge e mediazione risultino fondati entrambi su interdisciplinarietà, volontarietà e persuasione, mostrando notevoli affinità, pare che fino ad oggi – almeno per quanto a me noto – nella mediazione ci si preoccupi per lo più di mettere a fuoco e gestire gli aspetti cognitivi della negoziazione tra le parti soltanto nell’ambito delle singole procedure già avviate.
Del tutto trascurato risulta invece il possibile apporto dell’approccio di economia comportamentale a monte, già cioè nell’attività di divulgazione e promozione della mediazione nonché nella normativa che la riguarda, in cui concetti e metodi del nudge offrono invece la possibilità di venire utilmente applicati, in particolare per il corretto inquadramento preliminare della procedura e dei suoi costi.
Sotto questo profilo, un primo spunto potrebbe essere proprio quello di inquadrare la mediazione bancaria e assicurativa, anche a livello legislativo, quale attività avente un interesse pubblico in settori regolamentati che va al di là della semplice e pur rilevante funzione deflattiva del contenzioso giudiziale, adottando l’approccio già utilizzato del resto per analoghi strumenti ADR previsti in altri mercati regolamentati quali le telecomunicazioni e l’energia.
*Avvocato e Mediatore in Milano