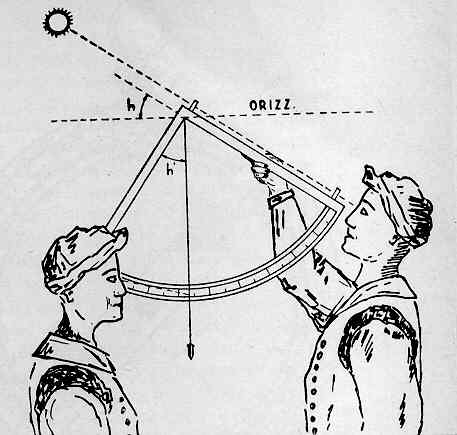
Può l’uso di un certo linguaggio creare un eccesso di aspettative? Vi sono pericoli nascosti dietro l’innocenza di una parola? È conciliazione una parola leale? Sono queste le domande da cui prende spunto questo breve scritto che cercherà di esaminare da una prospettiva poco considerata, perché il termine conciliazione potrebbe contenere in sé una contraddizione, valutando i rischi dell’uso del linguaggio e cercando possibili soluzioni.
In un’epoca di parole, l’uso di queste è spesso distratto. Ma il linguaggio guida la nostra comunicazione e s’innesta prepotentemente nelle scelte effettuate dagli utilizzatori di un servizio. Per questo motivo, i rischi di un linguaggio ambiguo non pre-occupano solo per problemi stilistici ma anche per le aspettative che possono crearsi e le conseguenti scelte che gli utilizzatori finali mettono in campo.
Nei vari dibattiti sorti negli ultimi anni sul tema della “giustizia alternativa”, il tema della creazione della fiducia sugli strumenti ADR nei confronti dei potenziali utilizzatori finali occupa una posizione di primo piano. Il concetto di fiducia richiama un’idea di lealtà con cui si presenta lo strumento. La lealtà si pone su due livelli; il primo, scontato, dell’istituzione che offre il servizio che deve lealmente presentare le regole, i costi ecc. e su questo nulla quaestio. C’è invece un secondo livello in cui si declina il concetto di lealtà che riguarda il come lo strumento presenta sé stesso. In altre parole, il secondo livello di lealtà riguarda un problema di linguaggio con cui la conciliazione si presenta.
In questa prospettiva, è conciliazione un termine leale?
Come sappiamo nell’ambito della macrocategoria della mediazione dei conflitti, il termine conciliazione viene usato per identificare la mediazione commerciale e cioè una procedura con la quale due o più parti cercano la gestione e la risoluzione del conflitto economico/commerciale che le oppone, assistite da un conciliatore – terzo, neutrale, imparziale e indipendente – che le aiuterà a trovare la loro propria soluzione al loro problema.
Ma qual è, in realtà l’aspettativa che l’utilizzatore finale può crearsi pensando la parola conciliazione? Il termine conciliazione pone problemi relativi al rapporto tra significante e significato?
Le poche osservazioni che seguono, più che certezze, vogliono essere lampi riflessivi sulle tematiche del linguaggio che nei dibattiti sulle “politiche pubbliche” stanno acquisendo importanza sempre maggiore. L’uso del linguaggio influenza la percezione che a sua volta influisce sulle scelte.
Scopro immediatamente le mie carte: credo che la parola conciliazione veicoli immediatamente l’attenzione verso un ipotetico risultato finale, la conciliazione appunto, verso il conciliare, e non tanto invece verso ciò che conduce a tale ipotetico risultato; in altri termini, l’attenzione verrebbe dirottata al momento finale e non alla dinamica intermedia (la procedura di conciliazione). Approfondendo leggermente si potrebbe anche pensare che l’utilizzo del termine conciliazione – se si accetta che questo richiami l’idea del risultato finale – contraddica con la natura stessa dello strumento che, come sappiamo, offre il “diritto” ad ottenere un aiuto da parte di un terzo – neutrale, imparziale e indipendente – nel tentativo di risoluzione di un problema che oppone due parti, ma non ad ottenere un risultato finale e cioè l’accordo e la conseguente conclusione della controversia. Il risultato non cambia se invece di affidarci ad una semplice e poco scientifica percezione, andiamo ad indagare l’etimologia dei due termini. Scopriamo subito che conciliare richiama il concetto di mettere d’accordo, mentre mediazione ha nel suo etimo il significato di essere in mezzo.
Se ci muoviamo dal campo della conciliazione e passiamo alle procedure ADR aggiudicative – in particolare all’arbitrato – ciò che l’utente finale “acquista” è il diritto ad una pronuncia, ad un risultato finale (positivo o negativo per lui non importa); tale struttura ben si adatta all’immediato significato prodotto dal significante arbitrato che richiama, istantaneamente, l’idea di qualcuno dotato di autorità di giudizio e del potere di definizione di una controversia. Possiamo perciò tentare di affermare che il termine “conciliazione” possa attivare nell’utente finale aspettative che vengono poi deluse dalla natura dello strumento che non rende certo il raggiungimento di un risultato finale. A questo proposito, mi pare legittimo chiedersi e riflettere se, in luogo di conciliazione, l’eventuale utilizzo del termine mediazione (commerciale) potrebbe parzialmente aiutare ad evitare l’ingenerarsi di false aspettative. Mediazione, al sottoscritto, evoca un significato molto più connesso alla fase dinamica che separa la lite dalla (eventuale) risoluzione. L’offerta del servizio di mediazione è quindi l’offerta, chiara anche in termini di linguaggio, non tanto di una modalità di risoluzione certa delle controversie, ma di un contenitore entro il quale l’esito positivo della controversia dipende anche e soprattutto dalla volontà e dalla capacità delle parti di volerlo. L’acquisto della mediazione non comporta, come invece avviene per l’arbitrato – ma anche per il processo ordinario – il diritto ad una soluzione del proprio problema.
Su questo specifico punto, secondo me, conciliazione potrebbe creare problemi di linguaggio e di aspettative.
di Carlo Riccardi





