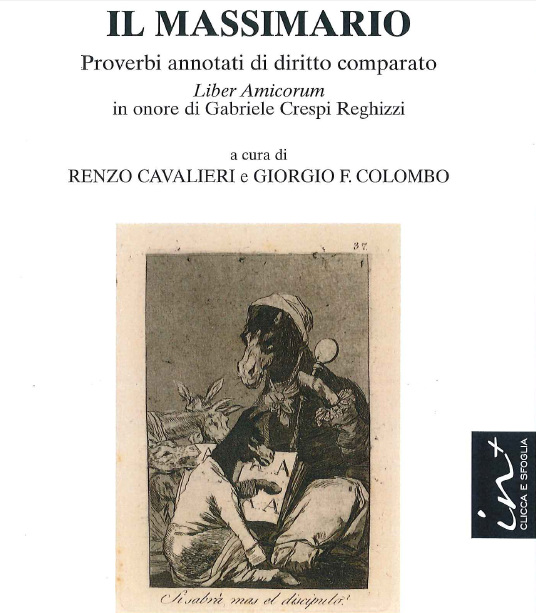 Siccome ogni tanto è lecito divagare e magari pure sorridere, proponiano un intervento di Giovanni De Berti: una riflessione lieve, eppure estremamente efficace, sull’utilità di dare (e ricevere) pareri. L’articolo è già apparso all’interno de “Il Massimario, proverbi annotati di diritto comparato – Liber Amicorum in onore di Gabriele Crespi Reghizzi, a cura di Renzo Cavalieri e Giorgio F. Colombo” Giuffré Editore.
Siccome ogni tanto è lecito divagare e magari pure sorridere, proponiano un intervento di Giovanni De Berti: una riflessione lieve, eppure estremamente efficace, sull’utilità di dare (e ricevere) pareri. L’articolo è già apparso all’interno de “Il Massimario, proverbi annotati di diritto comparato – Liber Amicorum in onore di Gabriele Crespi Reghizzi, a cura di Renzo Cavalieri e Giorgio F. Colombo” Giuffré Editore.
Un parere non richiesto fa piacere solo a chi lo dà
di Giovanni De Berti
La prima volta che, praticante avvocato, mi recai a Londra per un corso estivo di diritto inglese, scoprii l’esistenza di un settimanale di antico lignaggio, il Punch. Era un illustre esempio di quell’umorismo britannico che ha allietato la vita di molti di noi. E’ un segno dei tempi che sia ormai scomparso da anni.
Tutto cominciò con l’esortazione fattami dal marito della giovane coppia presso la quale dimoravo quale paying guest. Alla fine di una discussione serale con la moglie, rivolse a me, scapolo ventiquattrenne, questo interessante parere non richiesto (e in effetti, anni dopo, non seguito): “Giovanni, stay single!”.
Pochi giorni dopo, citando il detto parere ad un collega locale, appresi che esso era l’aggiornamento di quello dato ai lettori da Mr. Punch già nel lontano 1845: “Advice to persons about to marry: “Don’t” “, un parere – non richiesto – spesso dato dai genitori ai figli in casi specifici e già allora né gradito né seguito. Come evidentemente quello contenuto, nel 1854, in un libro di Benjamin Disraeli, che oggigiorno susciterebbe alzate di sopracciglia o peggio presso i custodi delle pari opportunità:
“Every woman should marry – and no man”.
Parlando di pari opportunità, recentemente ho dovuto preparare uno dei problemi da sottoporre ai partecipanti ad una competizione internazionale di mediazione commerciale. I coordinatori hanno sottolineato che i nomi delle parti in conflitto devono essere tali da poter essere interpretati da persone di entrambi i sessi. Ad esempio, “Terry” può bene adattarsi sia ad un Terence sia ad una Theresa. So far so good. Sottopongo una prima bozza, nella quale uso come pronomi ed aggettivi he, him e his: sono infatti cresciuto nella prassi universalmente ed anche legislativamente accettata che il maschile includa il femminile. Mi si fa notare che devo usare entrambi i generi anche in tali casi. Ricorro al faticoso – e a lungo andare un po’ noioso – he/she eccetera, ed invio la seconda bozza. Mi si suggerisce di usare she/he o addirittura l’impronunciabile s/he eccetera. Rispondo che questo mi sembra andare nella direzione della reverse discrimination, e che avrei usato le due versioni in modo alternato. Sono in rassegnata attesa dei commenti alla terza bozza.
Mi domando per quanto tempo ancora i nostri codici, ma che dico, la nostra costituzione, non saranno finalmente smascherati come sessisti e riformati in modo rigorosamente politically correct.
Ma sto divagando, ritorniamo ai pareri non richiesti.
Come avvocato alle prime armi imparai ben presto che i clienti si aspettano normalmente da noi un parere, non su cosa noi riteniamo sarebbe per loro opportuno fare, ma su come fare quello che loro ritengono opportuno. Giovane ed unico sostituto di un avvocato spesso assente, mi stavo confrontando con la richiesta di un cliente di instaurare una causa su presupposti giuridici a mio parere totalmente infondati. Mi ero dunque permesso di avanzare, peraltro in modo che a me era parso molto diplomatico, il suggerimento di investire il suo denaro ed il nostro tempo in un onesto tentativo di sistemare la questione con la controparte in modo conveniente per entrambi. Avevo senza saperlo anticipato il concetto di principled negotiation che anni dopo avrebbe resa famosa la scuola di Harvard e di culto il libro Getting to Yes dei suoi fondatori, Roger Fisher e William Ury, che ne illustra le basi teoriche e le tecniche applicative. Ignaro di avere a che fare con l’antesignano di una nuova era, il cliente in questione aveva espresso in modo cortese ma assolutamente trasparente il suo dubbio di doversi rivolgere ad altro studio. Solo una ritirata strategica mia ed un intervento che definirei chiarificatore del titolare dello studio aveva permesso di mantenere intatto il rapporto professionale. Avevamo così iniziato un’ardita causa che avrebbe dato molte soddisfazioni psicologiche al cliente, spero a parziale compensazione dei risultati non altrettanto soddisfacenti ottenuti poi nel merito.
Questa esperienza professionale è ben confortata da quella personale. Quando chiediamo un consiglio, non stiamo spesso, in realtà, chiedendo un supporto? La formulazione della domanda è quasi sempre una spia della risposta che ci aspettiamo di ricevere. Anni fa un amico mi chiese cosa ne pensavo dell’idea che lui abbandonasse la fiorente impresa di famiglia, ove a suo dire si trovava stretto tra padre autoritario e fratelli ambiziosi, per darsi a ciò che anni dopo sarebbe stato chiamato agriturismo. Cercando di barcamenarmi, gli dissi che la vita agreste era sempre stata uno dei miei sogni (in effetti lo è ancora e mi conforta pensare che sia rimasto tale). Evidentemente gratificato dalla mia risposta, l’amico si addentrò in dettagli progettuali che dimostravano come avesse già studiato a fondo ed entusiasticamente approvato tale alternativa. Ci perdemmo un po’ di vista, e qualche tempo dopo seppi che stava negoziando una composizione con i creditori.
Tornando all’esperienza professionale, non sono forse richieste di supporto i cosiddetti pareri pro veritate? Dato il loro nome, si dovrebbe pensare che il cliente sia veramente interessato a sapere come si profila la questione da un punto di vista giuridico e quindi quali siano le sue prospettive di prevalere o soccombere in un’eventuale disputa. In realtà questi pareri sono spesso chiesti al giurista a sostegno delle posizioni del cliente, per essere usati in negoziazioni o cause incombenti. E’ anche vero il contrario, ed a me come a molti sarà capitato di dare pareri diciamo cautelativi: ma questi sono rimasti riservatissimi, mentre il classico parere pro veritate è destinato ad una diffusione più o meno mirata.
E’ forse tale esperienza che mi ha portato, nel corso degli anni, a privilegiare l’arbitrato e la mediazione: sempre più, ed ora esclusivamente, nella veste di arbitro o mediatore.
Quanto ai lodi arbitrali, il ragionamento funziona così: se proprio devo dare un parere obiettivo, che almeno sia veramente richiesto, che sia veramente – nei limiti delle mie capacità – pro veritate, e che dia piacere, beh… ad almeno una delle parti.
Quest’ultimo punto mi porta a spiegare perché fare il mediatore sia diventata poco per volta una passione dominante nella mia tarda stagione. Devo rifarmi a quanto mi disse una volta una nota mediatrice olandese, che era stata per un ventennio magistrato, sino a diventare presidente di corte d’appello. Ad un certo punto, mi diceva, si era resa conto che, nonostante o forse a causa dei suoi sforzi per emettere sentenze giuste, spesso queste riuscivano a scontentare entrambe le parti. Si era dunque resa disponibile a varare nel suo paese il primo progetto di mediazione delegata, cioè proposta dai giudici: progetto iniziato appunto nel distretto della sua corte d’appello e diffusosi a macchia d’olio in pochi anni in tutti i Paesi Bassi, in una da allora citatissima success story della mediazione. Aveva infine abbandonato la magistratura per darsi a tempo pieno alla mediazione.
Infatti, cos’è giusto? Forse la risposta più sincera che ciascuno di noi dovrebbe dare è che è giusto ciò che a noi sembra giusto: ed è giusto il giudice che riconosce la giustezza delle nostre ragioni.
Perché dunque, invece di imporre ad una o peggio ad entrambe le parti un nostro concetto di giustizia, non aiutarle a cercare un accordo che entrambe siano pronte ad accettare come giusto?
Una transazione, dunque? Non proprio, non necessariamente.
Quando iniziai “quella lunga battaglia senza fine che chiamano la libera professione” (come un saggio prozio mi scrisse dopo la mia laurea), appresi dai miei maestri che la migliore transazione era quella che scontentava entrambe le parti. Aliquid datum, aliquid retentum significava proprio rinunciare a un pezzo di ciò cui ritenevamo di avere diritto per ottenerne almeno la parte restante. Impostazione abbastanza deprimente ma non priva di logica, visto che tentare o proseguire una causa poteva significare perdere tutto con l’aggiunta delle spese.
Nella mediazione, procedura informale e quindi non ingabbiata dal petitum o dalla causa petendi, il mediatore cerca invece di fare emergere quelli che sono i veri interessi delle parti ed aiutarle a trovare delle soluzioni, magari “creative”, che le soddisfino entrambe. Mi è capitato spesso di vedere le parti concludere con grande soddisfazione accordi che prescindevano dalle originarie posizioni di diritto e addirittura, viste dall’esterno, da criteri di logica.
A volte i veri motivi della disputa erano venuti in superficie, a volte erano rimasti sommersi nelle profondità del loro cuore. Come infatti Blaise Pascal ci ammonisce: “le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point”.
Così, dopo una lunga traversata tra pareri dati e ricevuti con o senza richiesta, sono approdato al porto tranquillo dove i pareri non si danno, neppure se richiesti. Devo ammettere che questo mi fa molto piacere.





